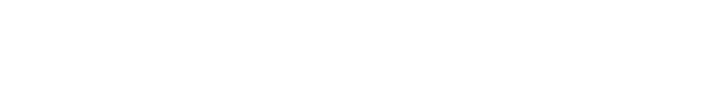DAVID BOWIE, LA MORTE E LA BELLEZZA. BlackStar, la fine segreta e il testamento-capolavoro del Thin White Duke, che si spegneva ieri notte
 Un capolavoro. È la prima cosa che mi è venuta in mente quando stamattina, al risveglio, ho sentito la voce di Marco provenire dall’altra stanza: “devo darti una notizia che non ci riguarda direttamente, ma che è molto brutta: è morto David Bowie”. Un capolavoro, e una trama genialmente lineare, ho pensato, ricordandomi di quando, lo scorso venerdì 8 gennaio, vale a dire appena tre giorni fa, nel giorno del compleanno della rock star di Brixton, ho condiviso un post dalla sua Fanpage Facebook ufficiale, con una foto che lo ritraeva sorridente, asciutto ed impeccabile nel suo completo antracite di Thom Browne, il borsalino e le Oxford nere indossate senza calze (solo lui, solo lui…), mentre la caption recitava:
Un capolavoro. È la prima cosa che mi è venuta in mente quando stamattina, al risveglio, ho sentito la voce di Marco provenire dall’altra stanza: “devo darti una notizia che non ci riguarda direttamente, ma che è molto brutta: è morto David Bowie”. Un capolavoro, e una trama genialmente lineare, ho pensato, ricordandomi di quando, lo scorso venerdì 8 gennaio, vale a dire appena tre giorni fa, nel giorno del compleanno della rock star di Brixton, ho condiviso un post dalla sua Fanpage Facebook ufficiale, con una foto che lo ritraeva sorridente, asciutto ed impeccabile nel suo completo antracite di Thom Browne, il borsalino e le Oxford nere indossate senza calze (solo lui, solo lui…), mentre la caption recitava:
“BUON COMPLEANNO David Bowie e ★
(Questo è il messaggio che ho inviato …)
Perché quest’uomo sembra così felice? Forse perché è il suo sessantanovesimo compleanno, ha appena pubblicato il suo 28° studio album ed è un “corker” (cioè una roba assolutamente fantastica)?
Chi lo sa, ma siamo sicuri che vorrete unirvi alle nostre congratulazioni per entrambe le cose.
Un augurio di felici riscontri nel giorno di David Bowie e ★
(Gli appassionati di moda potranno inoltre notare che il nostro uomo indossa Thom Browne)
Un successivo post ci informa che, ad un solo giorno dalla release ufficiale del testamento BlackStar (Sony, 2016), avvenuta proprio nel compleanno di Bowie, l’album era già primo per vendite iTunes e Amazon in UK e secondo negli USA. E che “Black Star” fosse un testamento lo sappiamo con certezza solo adesso. Adesso che la morte sopraggiunta scioglie le riserve del pudore che la gente di stile sa ancora riservare alle più capitali tra le esperienze, oltre il patto col diavolo dello star system, oltre ogni giornalistica rilevanza e convenienza. David Bowie è morto nella più assoluta discrezione della sua dimensione privata, non una soffiata, nemmeno il benché minimo tentativo di scoop fino all’annuncio di stamattina. Il capolavoro in questione, pertanto, è che, nel merito del tema della fine biologica, la “Stella Nera”, come egli stesso si canta nella title track dell’album nato nel giorno del suo compleanno, ci ricorda oggi che gli dei sono quelli che non hanno scordato che il nostro corpo che ama, s’ammala e finisce è solo affar nostro, di noi stessi e di quelli che, insieme con l’anima, c’hanno tenuti stretti tutti interi, caramente. L’implacabile esercizio di coerenza del camaleonte dunque, il quale, ancora giovanissimo, individuò nel fratellastro Terry Burns, capellone, ribelle e ascoltatore di jazz, poi scoperto schizofrenico e morto suicida, un modello musical-esistenziale, certamente all’insegna della diversità, della crepa del corpo-mente che però è generativa, della trasformazione. L’affilatissimo esercizio di coerenza di uno che sapeva che il corpo è insieme limite e strumento, tempio privatissimo e opera d’arte: glielo insegnarono il teatro, il mimo, la danza: «Da lui ho appreso il linguaggio del corpo», ebbe a dire del coreografo, attore, ballerino, mimo e regista britannico Lindsay Kemp, che gli fu maestro di teatro-danza e mimo, e poi prestigioso regista della pièce, scritta dal rocker, che dava il “la” ad una delle celeberrime trasformazioni del Duca Bianco, intitolata per l’appunto The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars: «ho imparato a controllare ogni gesto – proseguiva Bowie a proposito della lezione di Kemp – a caricare di intensità drammatica ogni movimento, ho imparato insomma a stare su un palco».
 Blackstar è un concept album della fine, una alchemica caccia al tesoro, disseminata di simboli, il cui suono è pervaso dalla voce del sax, il primo strumento della vita musicale di Bowie, perché un testamento è per eccellenza “à rebours”, un percorso all’indietro più che si può, alle origini archetipiche dell’infanzia. Ma il sound di Blackstar è scandito pure da scale arabe e nenie desertiche, ipnotiche o allucinate, che adesso sembrano cantare il presente, quell’Oriente di noi che oggi ci fa paura e la cui minaccia, che è la minaccia in noi, non riusciamo a decifrare. Una storia che Bowie sa già di dovere abbandonare e che consegna così nel suo scorrere a noi che restiamo. E, a proposito di Oriente, e della coscienza d’essere di passaggio: «Molto di quello che all’inizio mi aveva attratto del buddismo è rimasto con me – dichiarò David Bowie a proposito della sua esperienza col buddismo tibetano, nel 1967 – L’idea della transitorietà e che non c’è niente cui aggrapparsi pragmaticamente, che a un certo punto dobbiamo lasciare andare ciò che consideriamo a noi più caro, perché la vita è molto breve. La lezione che ho probabilmente imparato più di qualsiasi altra cosa è che la mia soddisfazione viene da quel tipo di investigazione spirituale. E questo non significa che voglio trovare una religione a cui aggrapparmi, significa cercare di trovare la vita interiore delle cose che mi interessano». E dunque buon ritorno a casa a te, Duca, che torni polvere, ma di stelle.
Blackstar è un concept album della fine, una alchemica caccia al tesoro, disseminata di simboli, il cui suono è pervaso dalla voce del sax, il primo strumento della vita musicale di Bowie, perché un testamento è per eccellenza “à rebours”, un percorso all’indietro più che si può, alle origini archetipiche dell’infanzia. Ma il sound di Blackstar è scandito pure da scale arabe e nenie desertiche, ipnotiche o allucinate, che adesso sembrano cantare il presente, quell’Oriente di noi che oggi ci fa paura e la cui minaccia, che è la minaccia in noi, non riusciamo a decifrare. Una storia che Bowie sa già di dovere abbandonare e che consegna così nel suo scorrere a noi che restiamo. E, a proposito di Oriente, e della coscienza d’essere di passaggio: «Molto di quello che all’inizio mi aveva attratto del buddismo è rimasto con me – dichiarò David Bowie a proposito della sua esperienza col buddismo tibetano, nel 1967 – L’idea della transitorietà e che non c’è niente cui aggrapparsi pragmaticamente, che a un certo punto dobbiamo lasciare andare ciò che consideriamo a noi più caro, perché la vita è molto breve. La lezione che ho probabilmente imparato più di qualsiasi altra cosa è che la mia soddisfazione viene da quel tipo di investigazione spirituale. E questo non significa che voglio trovare una religione a cui aggrapparmi, significa cercare di trovare la vita interiore delle cose che mi interessano». E dunque buon ritorno a casa a te, Duca, che torni polvere, ma di stelle.