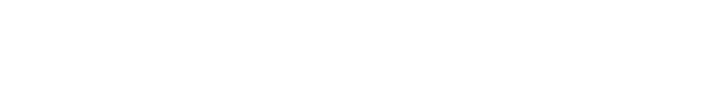LE PAROLE DI BLACKSTAR. I misteriosi testi dell’album-testamento di David Bowie raccontano davvero soltanto la sua morte?
Le parole di “Blackstar” (Sony, 2016) sono state un grosso problema per la maggior parte dei recensori, almeno fino all’altro ieri, quando moltissimi hanno creduto di potere trovare nella morte di David Bowie un’agnizione di senso, la soluzione di quel corpo enigmatico di simboli costituito dai testi dell’album. E tuttavia, è legittimo esaurire tutto il significato dell’album nell’esperienza della malattia e della morte, celate quasi al mondo intero? È soltanto la morte che sopraggiungeva, il messaggio? Oppure forse il poliedrico genio di Brixton ha provato finalmente a ritagliarsi per sé, compiutamente e organicamente come mai prima d’ora, lo spazio per parlarci di come ha vissuto la sua vita e la sua ispirazione, di quel sapere profondo, immaginifico, in una parola sola poetico, il quale fa di tutte le conoscenze una conoscenza sola?
Ivo Van Hove, che ha diretto Lazarus, lo spettacolo teatrale ancora in scena all’NYTW di New York, il cui plot è ispirato alla terza traccia e secondo ed ultimo singolo tratto da “Blackstar” e con protagonista Michael C. Hall (il Dexter televisivo, ma pure il fragile funeral director David Fisher di Six Feet Under), è tra i pochi a sapere da tempo dello stato di salute di Bowie, e, a proposito della narrazione di “Blackstar”, ha detto di un uomo al cospetto dell’abisso della morte «che trova in seguito una via d’uscita attraverso l’immaginazione, così da poter stare in vita e in libertà come un “bluebird”», l’usignolo americano che è stato l’araba fenice per molti songwriters e che il Thin White Duke canta così, proprio in Lazarus: “Oh, I’ll be free, just like that bluebird”.
L’immaginazione come antidoto alla propria finitezza, dunque. Non una fantasticheria consolatoria, ma piuttosto l’ “imaginatio” degli alchimisti che poi fu, per C.G. Jung, il suo celebre allievo Hillman e gli junghiani tutti, l’immaginazione attiva, quella sintesi simbolica e poetica, per l’appunto, che per il celebre psicanalista svizzero era facoltà irrinunciabile e radicata nelle strutture stesse della mente. E che ha forgiato dalle fondamenta il Bowie che, bambino, elesse a modello di ascolti e tensioni esistenziali quel fratellastro Terry che poi, schizofrenico grave, morì suicida, gettandosi sotto un treno; e ancora il Bowie della lezione, trasversale e trasformista del coreografo, attore, ballerino e regista britannico Lindsay Kemp, che gli fu maestro di teatro-danza e mimo, e che poi diresse The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars; e infine il Bowie della curiosità culturale per l’occulto, in particolare del pensiero dell’occultista, poeta e pittore britannico Aleister Crowley che prima studiò e fece proprio (in “Quicksand”, inserita in Hunky Dory del 1971, Bowie canta “I’m closer to the Golden Dawn/Immersed in Crowley’s uniform of imagery”, “Sono vicino all’Alba Dorata/Immerso nell’immaginario crowleyano”) per poi schermirsi, ricusandolo (in un’intervista del 1997 dichiarava spiazzante: «Ho sempre pensato che Crowley fosse un ciarlatano. Preferivo Edward Waite o Dion Fortune e il suo libro “Autodifesa psichica”: bisogna correre intorno alla stanza tirando pezzi di spago e vecchie calze e disegnando buffe cose sul muro, prendevo la cosa molto seriamente, ah, ah, ah ! Tracciavo porte su altre dimensioni: sono sicuro che, per quel che mi riguarda, ho davvero viaggiato in altri mondi: tracciavo segni sui muri e vi passavo attraverso e vedevo davvero quello che c’era dall’altra parte !»).
E così, nel cerchio magico delle parole della title track “Blackstar” è parso a molti di potere trovare queste “combinazioni”, a partire dai bellissimi versi d’apertura, “In the villa of Ormen […]/Stands a solitary candle […]/In the centre of it all”, dove il “villaggio di Ormen” è Ormr inn Langi (“il lungo serpente” in norvegese antico), agglomerato nei pressi di uno dei siti di gas naturale più impervi ed importanti al mondo. La “solitary candle” è così, fisiologicamente, il respiro della terra, ma pure la primigenia e insieme estrema luce, l’inconfondibile “light that never goes out”, di smithsiana memoria, la fiala di Galadriel con dentro la luce della stella di Eärendil, donata a Frodo dalla strega bianca del capolavoro di J.R. Tolkien, “Il signore degli anelli”, per essere una guida “[…] quando ogni altra luce si spegne”. E se è ancora Morrissey, stavolta quello di “Rubber Ring”, a cantare così la metaforica fiaccola: “I’m here with the cause/I’m holding the torch/In the corner of your room/Can you hear me?”, è il Buddha in persona, del quale Bowie seguì l’insegnamento presso i monaci tibetani verso la fine degli anni Sessanta, a sentenziare: “Migliaia di candele possono essere accese da una sola candela, senza che questa ne risulti intaccata”. Ma il tema “stellare”, notoriamente caro a Bowie, sembra venire anche dallo stesso Crowley: nel rituale magico chiamato “The Star Sapphire”, l’occultista scrive “Let him return to the centre, and so the centre of all”. Prima che l’album uscisse, infine, si era già ipotizzato pure il flirt di senso della title track coi rimandi alla Storia presente dello Stato Islamico e della jihad: l’ipotesi, forgiata sul riferimento testuale alle “esecuzioni” e sul fatto che Donny McCaslin, il musicista jazz che ha contribuito a creare il suond di “Blackstar”, ne aveva fatto cenno in un’intervista, pare prendere più corpo, benché sublimata in musica, nell’ascolto delle scale arabe e nenie desertiche che costellano il suono del disco, quasi a pennellare, ipnotiche o allucinate, quell’Oriente di noi che oggi ci fa paura e la cui minaccia, che è la minaccia del conflitto tra le culture che rechiamo con noi, endemicamente, e che non riusciamo a decifrare. Uno scenario epocale, che Bowie sa già di dovere abbandonare e che consegna così, nel suo scorrere, a quelli che restano. Ma “Io non sono una pop star, sono una blackstar” suona pure come un rito dell’immortalità, contro l’ipotesi di essere solo “flash-in-the-pan”, come Bowie canta a un certo punto, citando Martin Amis che così descriveva Ziggy- Bowie in un articolo del 1973 per New Statesman. Infine, “Blackstar” è l’icona che campeggia sulla cover, inequivocabile, la prima senza il volto di Bowie stesso, a ribadire la coscienza di questo viaggio simbolico da un mondo all’altro.
“Can’t Give Everything Away” appare altrettanto sibillina, ma in modo più potente e lineare; l’ultima traccia di “Blackstar” comincia con “I know something is very wrong”, “Io so che c’è qualcosa di profondamente sbagliato”, per continuare cantando di “cuori in blackout/news che fioriscono/e un teschio che prende forma sopra le mie scarpe”. In fine dei conti “I can’t give everything away”, il verso che da il titolo alla canzone, vale a dire “io non posso consegnarvi tutto”. Non ancora, almeno. E se in “Dollar Days” Bowie canta di prati inglesi che non sono più per lui, “Tis a Pity She Was a Whore” è un lapalissiano rimando allo sconvolgente (ed esoterico!) testo teatrale del drammaturgo inglese del diciassettesimo secolo John Ford, dall’omonimo titolo, storia d’amore incestuoso, morte e scabrosi rituali. Lazarus narra certamente l’identificazione col resuscitato da Cristo nel vangelo di Giovanni: “Look up here,” canta Bowie, “I’m in heaven”, già consapevole di ritrovarsi forse a cantare per noi questi versi dalla tomba; ma i versi finali della canzone “Oh, sarò libero/proprio come quell’usignolo/Oh, sarò libero/Che non è proprio come sono adesso” sembrano restituire una visione positivamente liberatoria della morte e suggerire una trascendenza. Infine, ancora in “Dollar Days”, Bowie canta “I’m dying to push their backs against the grain / And fool them all again and again”, sottile gioco di parole per “Muoio (dalla voglia) di spingere ancora le loro schiene contro il grano (laddove l’espressione idiomatica “agaist the grain” significa “contro le proprie inclinazioni” ma anche “oltre la comfort zone”)/e prendermi gioco di tutti loro ancora e ancora”. Ma se stavolta si tratta di un trucco, quel trucco, che non può riuscire a nessuno, è altrettanto vero che il peso specifico dell’influenza di David Bowie nella musica e nella cultura dell’Occidente contemporaneo gli permetteranno di certo, come l’araba fenice o il suo bluebird, di conoscere innumerevoli rinascite e nuovi voli, per decenni ancora.