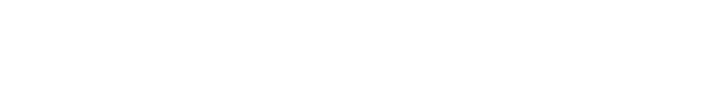WORLD PRESS PHOTO 2014. Basta le solite tragedie, entra il campo l’umano e il familiare
Non ci sono le solite tragedie, le classiche catastrofi altisonanti. Al World Press di quest’anno è successo qualcosa di diverso. Certo, di drammi collettivi ce ne sono sempre, e d’altronde è anche questa è l’essenza della notizia. Eliminarli dalle pagine del concorso più famoso del mondo, vorrebbe dire cancellare parte della storia. Eppure in quest’edizione 2014 non sono in predominanza.
Saranno state le critiche degli anni precedenti, saranno stati gli appelli ad un fotogiornalismo più originale e meno “facile”, sarà quello che volete, ma il World Press ha scoperto il suo volto umano. Segue finalmente quella virata verso il racconto intimo e personale che da tempo la fotografia urla con decisione. È l’essenza della visione d’autore che lavora sulle singole identità. Al sovraffollamento di immagini dell’attuale società si contrappone il privato, profondo e familiare.
E così il Word Press assegna la vittoria ad una foto, “Signal” di John Stanmeyer della VII Photo Agency, che mostra lungo la costa di Gibuti alcuni migranti africani che alzano al cielo i loro telefoni cellulari, per catturare il segnale dalla vicina Somalia e contattare i parenti lontani. Al di là dell’immaginario che sollecita (a me ha ricordato per esempio una pubblicità di telefonini) racconta un momento intenso, non scatenato da nessun cataclisma particolare.
Oppure anche quando la disgrazia è evidente, questo WPP privilegia uno sguardo confidenziale, stretto come “Final Embrace” di Taslima Akhter, che ritrae una coppia abbracciata tra le macerie del crollo di una fabbrica in Bangladesh. Oppure lo scatto del centro profughi di emergenza in Bulgaria, di Alessandro Tempo dal titolo “Temporary Accommodation”, che con le sue tende fatte di lenzuoli bianchi sa molto di posto riparato e domestico, dove noi estranei andiamo a sbirciare.
Nelle case entriamo anche con Sara Naomi Lewkowicz e il suo “Portrait of domestic violence”. Una famiglia, appunto, dove avvengono violenze. Il fotografo ci fa assistere a tutto, ai baci, agli strilli, alle aggressioni, senza filtri patinati ma neanche fragorosi. Basta la foto, semplice.
Ecco allora che una bambina nascosta in un angolo del suo orfanotrofio (“Nicolette at the orphanage” di Maciek Nabrdalik), con la testa abbassata, composta, dice molto di più di un pianto strepitato; ecco che si può mostrare l’intimo di alcune giocatrici della squadra di football americana, quasi come fossero mutande e reggiseni appesi in un bagno qualunque (“A lingerie league of their own” di Alyssa Schukar).
Il mondo è pronto finalmente per scoprire qualcosa di più della vita in Palestina, al di là del velo nero dei burka (“Occupied Pleasures” di Tanya Habjouqa) o dell’Africa, oltre i corpi sofferenti di bambini affamati e in fin di vita: con Robin Hammond in “War and mental health after crisis” scopriamo i manicomi in Somalia e i suoi abitanti, con Jana Asenbrennerova in “Living Unnoticed” il trattamento degli omosessuali in Congo.
Ci sono poi le storie della gente, pure e essenziali. Come il trascorrere dei giorni nella buia e inquinata Norilsk, in Russia, con “Days of night – Nights of day” di Elena Chernyshova”. E il racconto delle attività di un piccolo villaggio rurale in Transilvania (“Built on grass”) di Rena Effedi. Autrice che vince anche con il ritratto (“Dasan, Spirit lake reservation”) del piccolo Dasan, della tribù dei Sioux. È sufficiente mostrare i suoi capelli al vento per dirci dello spirito del suo popolo. Infine anche Carla Kogelman con “Ich bin waldviertel” cattura i quotidiani giochi di due bambine in Austria. Sebbene l’idea non brilli né in singolarità (vedi “The adventures of guille & belinda” di Alessandra Sanguinetti) né in esecuzione (vedi “Family Pictures” di Sally Mann).
Ciò che accomuna però questi progetti è il fatto di non dire assolutamente nulla. Nessuna notizia, è l’avvento del banale, degli squarci comuni di esistenza, che non per questo sono meno originali. Chi sapeva degli eremiti russi che vivono quasi nascosti nelle riserve (“Escape” di Danila Tkachenko) oppure del campo di nudisti dell’isola di Utrish (“Utrish” di Nikita Shokhov)?
Queste immagini vogliono dirci che nessuna trovata è più interessante dell’ordinario e delle persone. Al punto che anche il bonobo di Christian Ziegler (“Bonobos- Our unknown Cousins”) sembra guardaci con sguardo umano.
Info: http://www.worldpressphoto.org/
Giuliana Calomino