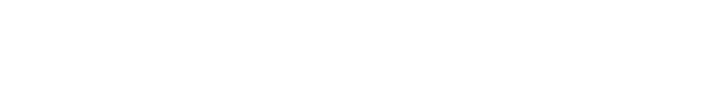IN RICORDO DI PRINCE. Le good vibrations del live al Palalottomatica del 2010 e la prova che l’autentico genio è sempre generoso
Muore d’improvviso The Artist Formerly Known As Prince, al secolo Prince Rogers Nelson, trovato per caso esanime nella sala di registrazione della sua casa/spazio musicale polifunzionale di Paisley Park. L’artista si era già sentito male lo scorso 15 aprile, mentre era in viaggio, tanto che il suo jet privato dovette ricorrere ad un atterraggio d’emergenza in Illinois. Poi la diagnosi d’influenza e la ripresa repentina, ed infine il triste epilogo di qualche ora fa.
Nato nel 1958 nella provincia imperiale di Minneapolis, Minnesota, The Artist comincio alla Warner Bros, Nel 1978, nel senso che tutto ciò che fu chiamata a fare la Warner fu di dargli una sala d’incisione e un suo uomo, il produttore Tommy Vicari, il cui ruolo finì per essere quello di mero budget controller del ventenne brevilineo polistrumentista il quale, chiusosi in studio per qualche mese in completa solitudine, ne venne fuori con “For You”, prodotto, scritto, suonato ed interpretato, per l’appunto, da Prince.
C’è già tutto il senso di un talento indomabile dentro questo esordio da storia della musica di tutti i tempi. Nel 1984 l’esordio folgorante con “Purple Rain”, contemporaneamente la prima posizione nelle classifiche dei singoli, degli album e dei film. Prima di lui soltanto i Beatles di Hard Day’s Night (compresa l’omonima pellicola interpretata dai Fab Four), ma anche Prince ebbe il suo “Purple Rain” movie, che gli valse l’ennesimo riconoscimento, l’oscar alla colonna sonora, manco a dirlo, più un Golden Globe per la indimenticabile When Doves Cry.
Con Love Symbol Album del 1992 l’abbandono del nome Prince per l’estremo TAFKAP, The Artist Formerly Known As Prince, gesto iconoclasta e spartiacque nell’ambito delle dinamiche di rapporto tra i super-artisti e le major, in particolare quella Warner-matrigna che ne fece il soggetto, il più giovane della sua storia industriale, di una totale indipendenza produttiva. E in tempi più recenti, la battaglia coi servizi di streaming online, Youtube e Spotify in testa: “Ciò che intendevo veramente era che Internet era finito per chiunque volesse essere pagato e avevo ragione. Ditemi un solo musicista che si sia arricchito con le vendite digitali. Anche se Apple ha fatto cose interessanti, vero?”, dichiarò nel 2010 al Guardian, salvo poi ripensarci e concedere un’esclusiva a Tidal, lo scorso anno.
Trentanove album di studio, diciassette colonne sonore, quattro album live sono solo alcuni dei numeri del prolifico genio il cui cassetto era pieno, giurano i bene informati, di partiture per chiudere forse altrettanti dischi.
Ambiguo, anzi no, genderless ante litteram, basso ed esile, poco meno che nero e poco più che mulatto, arbitro di bizzarrie più che di eleganze, si esibì in slip e tacchi a spillo senza perdere un grammo in virilità e sex appeal, indossò sunglasses a tre lenti e tutte le pettinature, dai boccoli post romatici all’afro look alle rasature punk; amò e venne soprattutto forsennatamente desiderato da donne bellissime, a lasciare a tutti gli altri maschi, ossessionati dalla loro bellezza oppure dalla loro bruttezza, una sonora, è il caso di dirlo, lezione: esiste una roba che si chiama “carica”, che riguarda la vita incontenibile, la libertà di darsi tutti interi, il sesso come linguaggio, ben oltre il guscio del corpo. Ecco, quella roba lì è irresistibile, e The Artist non ha perso una singola occasione per ricordarcelo.
Il ribelle ad ogni costo, il musicista capace di suonare (e scrivere per) diciassette strumenti musicali, come i grandi compositori della musica di repertorio del passato. Io l’ho ricordato riascoltando Art official age del 2014, un album folle, sopra i generi, che somiglia solo a se stesso, esattamente come Price. Ed ho ripercorso, canzone per canzone, il ricordo di uno dei concerti più belli a cui abbia mai assistito: si trattava della prima delle due tappe italiane del 20TEN Tour 2010, quella romana del Palalottomatica, il 2 novembre più caldo e vitale che ricordi. Prince mancava dall’Italia da otto anni, le aspettative erano alle stelle. Venimmo a sapere che, seminascosto dietro i vetri della tribuna stampa c’era Lenny Kravitz, in tour in Italia pure lui: qualche ora dopo l’avremmo ritrovato che si sbracciava con gli occhi lucidi, come un fan qualunque, come tutti, noi. Il concerto, dal trentacinquesimo studio album dell’artista, lo vedeva in giro con una doppia band che prevedeva, tra gli altri, la mitica batterista Cora Coleman, e che considerava un set mai inferiore alle trenta canzoni. Un bagno di funk, R&B, r’n’r, grunge, blues, e dei suoi assoli rutilanti, enciclopedici eppure senza paragoni. Prince tornò poi in palco senza band, ancora in costume di scena, più di mezz’ora dopo che le luci di sala erano state accese, e si esibì per altri 45 minuti soltanto con la chitarra elettrica e la sua voce per pochissimi di noi, oramai tutti stretti sotto il palco, che proprio non si erano voluti arrendere ad andarsene. Ti avrei ascoltato ancora, me lo ero ripromesso, ma certi giri perfetti non ripassano, e già è tanto averli goduti una volta. Addio genio libero, strafottente, inafferrabile, e per questo stra-sexy.